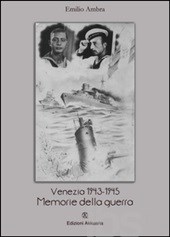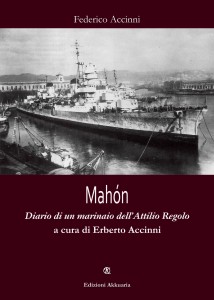Le Giornate della Memoria
24 maggio 1915 – 25 aprile 1945 un trentennio fra due guerre
17 settembre 2015
I Diari della seconda guerra mondiale
La collana ha volutamente considerato un periodo storico di 30 anni, e la scelta è stata dettata da una ragione ben precisa.
Per non pochi aspetti, nel 1914 l’Europa cominciò un gioco mortale che si concluse soltanto nel 1945, da qui la scelta di considerare un trentennio, e non soltanto le due singole guerre mondiali.
Com’è noto, alla pace di Versailles nel 1919 si presentò un’Europa molto diversa da quella che 4 anni prima aveva iniziato il conflitto: 4 imperi erano spariti, e in virtù della proposta del presidente americano W. Wilson sull’autodeterminazione dei popoli, nuovi stati nascevano: Cecoslovacchia, Romania, Ungheria, Iugoslavia; la Polonia ricomposta guadagnava l’accesso al mare a spese della Germania: il corridoio di Danzica.
Mi è sempre parsa – seppur non priva di principi democratici e certamente con intenti più ispirati alla dignità dell’uomo – una riedizione moderna della cinquecentesca risoluzione di Lutero del: cuius regio eius religio.
Territori passavano di mano: Alsazia e Lorena dai Tedeschi ai Francesi; Estonia, Lettonia e Lituania erano tolte alla Russia e divenivano stati cuscinetto.
A Versailles fu firmata una pace ingiusta. Al tavolo sedettero soltanto i vincitori, che imposero alla Germania e all’Austria inaccettabili e umilianti condizioni di resa. Ma nemmeno i vincitori ebbero grandi guadagni: in Francia ci si domandava se 1.200 mila giovani francesi morti fossero davvero un buon affare per 700.000 kmq di territorio.
L’Italia ne uscì scornata: riuscì a rivendicare poco di quello che le era stato offerto dalla Triplice Intesa per entrare nel conflitto. Ebbe una fettina dell’Adriatico ma meno rispetto alle aspettative, che comunque fecero definire il 4 novembre 1918 “una pace mutilata”.
Purtroppo un altro aspetto introdusse il conflitto moderno: il sistematico uso della violenza per risolvere i problemi politici.
L’insoddisfazione generale provocò moti di ribellione in tutta l’Europa postbellica, cavalcati dai partiti socialisti delle nazioni; l’esempio che veniva dall’est infiammò le classi lavoratrici e preoccupò i governi, che trovarono legittimo proseguire le repressioni dei propri popoli con i metodi della guerra, per la paura di una presa di potere socialista, ma più ancora comunista.
Da quella pace ingiusta vennero tutti i guai successivi: in Italia in fascismo, in Germania il nazismo, in Spagna il franchismo, ma anche i regimi assoluti di fede comunista in Romania, in Bulgaria, in Turchia, in Polonia. Quella pace ingiusta partorì l’idea scellerata che soltanto con l’uso della forza si poteva ottenere vendetta, come sinonimo di giustizia.
Ne derivò così la seconda avventura, più feroce della prima, nella quale i nazionalismi poterono sfrenarsi in una ideologia perversa e mortale che durò quasi 6 anni e mise in ginocchio tutta l’Europa per molti anni a venire. Un calderone che bruciò molte vite e parve cancellare ogni ideale di giustizia, umanità, pietà.
Parlando della relazione che lega le due guerre, non è neppure possibile ignorare gli anni che stanno in mezzo, che videro comunque conflitti sanguinosi che non lasciarono mai spazio alle regole del diritto: conflitti forse minori ma con il loro bravo bagaglio di morte e distruzione.
Anche in questa giornata conclusiva nel percorso della memoria eviteremo le citazioni di orrore e ripulsa: mi parrebbe una sorta di racconto che facciamo fra noi mentre fuori di qui tutto prosegue indifferente ai buoni propositi.
Dato per ovvio che portano lutti, disgrazie e decimano le famiglie; che sicuramente ci sono altri modi per risolvere le controversie, osservo soltanto che – da sempre – l’uomo fa la guerra.
È giusto? È sbagliato? Non so rispondere. È un modo sbrigativo per risolvere i problemi di sovrappopolazione. Malthus la indicava come una necessità per mantener equità fra le risorse alimentari e le bocche da sfamare. Von Clausewitz la definiva la “prosecuzione della politica con altri mezzi”.
Osserviamo che sempre – prima di dichiararla – il Capo del governo di turno la definisce inevitabile soluzione, e invoca l’aiuto di Dio per vincerla, mentre i cappellani militari benedicono le armate che scanneranno il nemico.
Serve? L’osservazione sociologica ci dice che sicuramente convoglia il bisogno di violenza e prevaricazione che è insito nella razza umana in una follia collettiva legittimata dal diritto.
Si è migliori, dopo?
A qualche chilometro da qui sbarcano clandestini che nessuno vuole. Non pochi pensano che è giusto mandare le nostre navi sulle coste della Libia ad affondare i barconi che li trasportano: non sarebbe un atto di guerra?
Quante volte lo Stato si è dichiarato in guerra contro la mafia e le cosche camorristiche?
Ragione, torto… alla fine diventano questioni accademiche. Di certo c’è che quando uno vuole qualcosa, il metodo più usato per averla è dichiarare guerra.
Tralasciando il lunghissimo elenco delle ragioni buone e cattive che rendono poi necessari i giorni della memoria come questo, mi è venuto da chiedermi quanto queste giornate possano servire.
Se non ce ne ricordiamo noi, né se ne sono ricordati i nostri padri al momento giusto, per quale ragione dovrebbero ricordare e far diversamente le generazioni future, oggi più che nel passato costantemente esposte a sollecitazioni violente?
Come sempre credo che queste osservazioni siano valide per esigue minoranze, che forse hanno più buona volontà di altre. Minoranze che però – al momento giusto – non hanno mai voce in capitolo e nemmeno potranno far ragionare gli scalmanati che invece vogliono la guerra.
Forgia gli animi, i caratteri? Sì, perché non dovrebbe? Ogni momento duro lo fa. Ma ho da obiettare sulla necessità di fare una guerra per rafforzare i caratteri, perché in qualche misura sarebbe ammetterne la necessità.
Stimola sentimenti di ripulsa per la violenza? Acuisce i sensi vedere l’orrore che si trascina dentro e fuori e prima e dopo? Ancora una volta sì.
Ma la vera domanda è un’altra: ne abbiamo davvero bisogno?
E qui davvero non so dare una risposta.
Come sempre, sull’argomento si sono spesi oceani di saggi, libri di memorie, biografie, diari, testimonianze, racconti, analisi psicologiche dei soggetti in causa.
Ognuno ha raccontato, la propria visione, il proprio punto di vista; spesso è rimasto soltanto questo: il punto di vista, che è sempre diverso fra quelli che l’hanno combattuta e quelli che l’hanno dichiarata.
Personalmente ho sempre trovato più interessante leggere le osservazioni dei piccoli che le hanno combattute piuttosto che le motivazioni dei grandi che le hanno dichiarate.
Ho trovato più verità in piccoli racconti che nelle grandi ragioni degli statisti e dei capi di governo, che non hanno saputo trovar altro modo che dichiararle, con la farisaica ammissione di averlo dovuto fare obtorto collo.
Ma questa è anche una kermesse letteraria. Lo scopo non è di stigmatizzare la guerra giacché ognuno di noi se lo può fare individualmente senza il bisogno di sentirselo dire qui.
Così è buona cosa lasciarsi permeare da sentimenti di orrore qui, in questo luogo; ma sarà cosa migliore portare questo sentire con noi, fuori di qui, e domani e domani l’altro, cosicché diventi un monito da portarci dentro, da evocare nei momenti confusi della nostra vita.
Per quanto ci siamo proposti impiantando la collana che raccoglie gli scritti sull’argomento, vogliamo soltanto rendere un poco onore a chi in quel crogiolo ha dovuto spendere una parte della propria giovinezza.
Ho preso in esame due diari, sui quali ho lavorato per la revisione (poca in verità) dei testi. E lavorando sorgevano delle considerazioni, dei paralleli e delle analogie.
Così ho pensato che potesse essere più interessante comparare gli scritti, e guardare poi i volti del pubblico per vedere se giungerete al mio stesso pensiero finale.
Ne propongo un esame filologico.
Essendo una carrellata nella memoria, voglio ricordare molto velocemente la letteratura sull’argomento.
Molti sono arcinoti; li cito disordinatamente e soltanto alcuni: Emilio Lussu, Un anno sull’altipiano – Ernest Hemingway, Addio alle armi – Mario Silvestri, Isonzo 1917, Diario di Caporetto di C.E. Gadda. Ci sono poi resoconti più imponenti: la Storia della seconda guerra mondiale di Winston Churchill, Gli ultimi in grigioverde di Giorgio Pisanò. Sono soltanto esempi…
Esiste però anche una letteratura meno conosciuta ma non per questo meno reale e veritiera. Sono i diari scritti dai combattenti che dal loro punto di osservazione hanno visto e portato a casa ricordi rimasti per tanto tempo indelebili.
Oggi saranno presentati dei libri, e di tutti mi piacerebbe poter dire qualcosa. Ho letto narrazioni maschili e femminili e ho trovato riflessioni toccanti in entrambi. Questo perché coscienza, pietà e sentimenti non hanno sesso. Ma per questa giornata mi è stato proposto di presentarne due in particolare.
Sono il racconto di mio padre e quello del padre di Vera.
Entrambi narrano la loro vita: curiosamente entrambi prendono in considerazione lo stesso periodo della guerra, dall’8 settembre ’43 al 25 aprile ’45.
Due circostanze li accomunano: erano in forza alla Marina Militare, ed entrambi – per diverse motivazioni – sono legati a un luogo: l’arsenale Militare di Venezia; mio padre perché fu allievo della Regia Scuola Militare dei Macchinisti Navali (che era nell’Arsenale) e il padre di Vera perché – dopo l’arruolamento – fu destinato proprio all’Arsenale.
Occorre una breve precisazione: nessuno dei due autori comparati è uno scrittore di mestiere. Finita la guerra hanno vissuto facendo quello che sapevano fare o che hanno dovuto imparare a fare; l’uno dando le dimissioni dalla Marina e iniziando un nuovo lavoro, l’altro riprendendo il mestiere che faceva prima della guerra.
Dei loro diari, sin dalle prime righe subito colpisce l’incipit.
Comune a entrambi è la capacità di entrare direttamente nell’argomento con una frase breve.
Comune è anche la capacità di inquadrare brevemente ed esaustivamente il momento storico che stanno vivendo.
Raccontano: senza fronzoli né giri di parole; e l’efficacia di questo stile è immediata e proietta nell’azione come una ben azzeccata scena iniziale di un film. Riescono a renderci esattamente, con una breve frase, chi sono, dove sono, che momento storico vivono e cosa stanno facendo.
Ho sempre ammirato chi con poche e misurate parole riesce a catturare la mia attenzione; chi, con semplicità, riesce a portarmi “dentro” quello che mi vuole dire.
Proseguendo nella lettura notiamo le diverse motivazioni, e qui il confronto si fa interessante. Sono diversi i personaggi che raccontano: uno è un militare di carriera che ha scelto di servire la Patria in armi; l’altro è un civile, che ha scelto per sé una vita di lavoro e che – per scelte scellerate altrui – si deve accollare anni di vita non suoi, non scelti da lui.
Per ovvie ragioni il modo di raccontare è diverso.
Per mio padre il racconto ha l’impronta del rapporto, del verbale: i fatti nella loro cruda essenza, le azioni, le conseguenze; è il punto di vista che è divenuto proprio quando ha scelto per sé la carriera militare. Il racconto è spesso reso usando il tempo verbale presente, o al più al passato prossimo per rendere l’immediatezza.
Nell’altro il tono è più discorsivo, più sfumato ma che diventa formale quando deve raccontare cose non previste per la propria vita. Poiché nei suoi anni di guerra si è dovuto impiegare nella Pubblica Sicurezza di Venezia, il tono è quello dei verbali che a volte fa sorridere. Sicuramente avrete sentito parlare in televisione il maresciallo dei carabinieri, il questore o il commissario: il loro stile è sempre uguale: al tempo imperfetto indicativo: “recatici in località xxx constatavamo che… in tutto pertinente al fatto lamentato dal denunciante, il quale asseriva che, in quanto… “.
Sono cliché espressivi usati per descrivere i fatti, dando poco spazio alle emozioni, e per questo efficaci allo scopo: verbalizzare come si svolgono gli episodi narrati, quasi per consentire ad altri di provare – leggendo – le “proprie” emozioni.
Se confrontate un “verbale di perdita di motoscafo” redatto da una commissione di Marina e un verbale delle forze dell’ordine pubblico, sempre troverete descritti i fatti, le cause e gli effetti. Potrà venirvi da sorridere, magari farete confronti con i diversi stili degli scrittori di professione, ma una cosa non vi sfuggirà: se lo scrittore di professione vuole raccontare una guerra o un incidente in cui abbiano perso la vita dei personaggi, dovrà per forza “usare” gli stessi termini tecnici che potete leggere nei verbali.
Il lessico deve essere identico: se si vuole descrivere che a seguito dell’esplosione, a bordo l’acqua è arrivata al trincarino, non vedo come altro lo si potrebbe dire. Se l’auto, a causa della forte velocità, sbandava finendo fuori strada rovesciandosi e sbalzando il passeggero dal finestrino… così lo dovrà dire.
In questi stili espressivi formali, soltanto apparentemente resta in ombra il narratore. Perché seppur deciso a riferire i fatti, egli racconta ciò che ha visto, che ha toccato la sua coscienza. Dal suo modo di comporre la frase, leggendo anche soltanto con interesse, potrete veder trasparire il suo sentire, il suo stato d’animo. L’emozione o il sentimento, anche se trattenuti, appaiono e coinvolgono al pari di una bella frase ben descritta dallo scrittore di mestiere, giacché gli autori – che raccontano in prima persona – non sono cinici professionisti della violenza.
Così di entrambi possiamo capire il profondo dissenso verso azioni indegne della dignità dell’uomo, che nessuna violenza della guerra giustifica.
Sono narrate con pudore? Forse, ma per l’intento di proteggere il nucleo più sensibile di sé da situazioni di fronte alle quali il giusto si ribella; e allora tutto il vissuto narrato acquista un senso: ci pone di fronte al rifiuto dell’ingiustizia, alla ferma e decisa volontà di non accettare e non giustificare mai, e soprattutto non addormentare la propria vigile coscienza.
In parole concise: non diventare un ingranaggio della macina.
Il dovere da compiere non è trascurato, ma è compiuto secondo le proprie regole, fedeli a un proprio codice di umanità che diviene – nei fatti contingenti – il solo modo accettabile di agire.
Se consideriamo allora questi aspetti, molto ci hanno lasciato da leggere. Nessuno di loro due si considera un eroe. Entrambi desiderano soltanto compiere il proprio dovere nel modo più pulito.
D’innanzi a episodi che possono far vacillare, “sapere chi sono” li mantiene fermi nelle decisioni, rafforza la loro volontà di non tradire se stessi e i valori in cui credono: non si agisce ingiustamente soltanto perché ora tutto pare ingiusto.
In quei terreni difficili, matura e si rafforza il loro codice di vita, il loro codice d’onore: silenziosamente alimentato da ciò che gli occhi vedono e la propria forza morale definisce sbagliato. Un codice che sarà loro per tutta la vita.
Coerenza. Io non ho mai ritenuto saggio essere coerente con le scelte fatte o subite in gioventù. Se può avere un senso essere milanista o juventino sin dalla nascita, non mi pare sensato essere fedeli a un ideale senza mai metterlo in discussione o conoscendolo soltanto superficialmente.
Così coerenza per me è restare fedeli a se stessi, alla propria natura di uomo che si ascolta e si sa interrogare, sempre ammesso che uno voglia e possa e sia capace di discutere se stesso. Una qualità non così comune quanto l’umanità necessita. E allora forse le guerre sarebbero dei conflitti interiori da non far combattere ad altri.
Spenderò poche parole ora su mio padre; non oso farlo per quello di Vera giacché l’ho conosciuto soltanto tramite i suoi scritti.
Nella scuola militare imparò i concetti di disciplina e onore che gli furono sempre ben presenti, ma anche l’autorità, e come esercitarla. Col tempo imparò a trasformarla in autorevolezza, qualche volta riuscendoci.
Essendo peraltro una natura curiosa e aperta a ogni tipo di pensiero e di apprendimento, non si vergognava di non sapere. Nella ricerca del concetto essenziale di Giustizia, la sua mente poteva mutare parere e riflessione; esaminava gli aspetti delle questioni da più lati, senza preclusioni ideologiche. Voleva la verità, non l’ideologia; il silenzio invece dei paroloni.
Spesso mi son chiesto se era questa la sua natura o se la vita l’avesse trasformato facendo divenire così. Lui sosteneva il libero arbitrio e le scelte coscienti che un uomo fa, pur ammettendo di essere stato “trascinato” in qualche circostanza.
Io non saprei dire; ancora mi sto dibattendo in una domanda che sarà sempre senza risposta: se le nostre azioni siano frutto di libera scelta o se sono già scritte nel libro di ciascuno, e così altro non resta che fare ciò che il libro comanda, con l’illusione di scegliere per la propria vita mentre in realtà si è agiti.
In quest’ultimo caso, poco merito avrebbe per essersi tenuto fedele alla propria coscienza di uomo.
Noi che abbiamo letto i loro racconti siamo ora testimoni di un fatto che ci piace riferire. Per lungo tempo le loro storie sono rimaste silenziose, sconosciute.
Se era destino che dovessero essere rese pubbliche, questo è avvenuto per entrambi dopo la loro morte.
E anche qui: non so dire se Vera ed io abbiamo qualche merito o se era scritto nel libro e abbiamo agito di conseguenza, però ora i diari ci sono, per ricordare anche queste due voci che hanno provato orrore e pietà di fronte alla barbarie.
Erberto Accinni